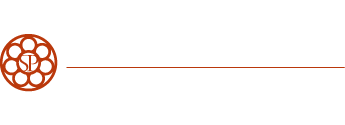DETTAGLI DEL CORSO
Il corso è articolato in 1 lezione di 1 ora e 30 minuti, di cui un’ora dedicata alla formazione più la discussione.
Già prima della Pace della Chiesa Roma ha una sua rete fatta di luoghi di riunione e di culto e di luoghi di sepoltura cristiani. Un patrimonio edilizio che si espande secondo necessità più che secondo una precisa decisione, che viene organizzato a posteriori più che essere amministrato a priori. La Pace della Chiesa cambia le carte in tavola, perché nella città e attorno ad essa nascono luoghi finalmente ufficiali, che in parte si trovano dove già erano quelli ufficiosi, in parte vengono edificati ex novo con delle scelte che cambieranno per sempre il volto della città. Una per tutte: il luogo della sua cattedrale.
Alla metà del VI secolo, alla fine della Guerra Greco-Gotica, Roma ha una sua identità cristiana ormai inequivocabile e perfettamente visibile: l’ultimo capitolo è la trasformazione in chiese dei templi pagani, compiendo così la naturale trasformazione da capitale di un impero a capitale di una fede.
Introduzione al corso e sviluppo della capitale cristiana
La lezione si apre con una panoramica del corso, focalizzandosi sullo sviluppo urbanistico di Roma dall’età romana fino al Rinascimento. Viene così presentato il contesto di transizione della città, con un’attenzione particolare alla crescita del patrimonio edilizio ecclesiastico.
L’identità cristiana di Roma nella lunga antichità
Nel corso della lezione, viene approfondita la trasformazione dell’identità di Roma, che, a partire dalla metà del VI secolo, si afferma come centro cristiano con un’accettazione sempre più visibile della religione cristiana. Si discute come la transizione da capitale pagana a capitale cristiana non sia stata un mero atto di imposizione, ma un processo naturale che ha attraversato secoli, portando alla ristrutturazione di templi in chiese e alla creazione di nuovi spazi di culto.
La tarda antichità e la cultura della transizione
La fase della tarda antichità viene esaminata come un periodo di coesistenza religiosa e culturale, caratterizzato dalla presenza di diverse fedi e dalla nascita di una nuova cultura che riprende alcuni elementi del classicismo. Si analizza oltretutto l’impatto del trasferimento della capitale da Roma a Milano e la continuazione dell’importanza simbolica di Roma come sede di prestigio nonostante la perdita del ruolo amministrativo.
L’impulso dell’Editto di Milano e il ruolo dell’imperatore
Con l’Editto di Milano si segna un momento cruciale nella libertà di culto cristiano, assegnando valore all’autorità imperiale e ridisegnando le relazioni tra religione e politica. Si riflette sulle implicazioni di questo editto, sugli atteggiamenti dell’aristocrazia pagana a Roma e sulla risposta di figure chiave come Sant’Ambrogio, sottolineando la tensione tra le diverse correnti religiose presenti nell’Impero.
La trasformazione urbanistica di Roma
Un aspetto cruciale è la trasformazione urbanistica di Roma, dove nuovi poli religiosi nascono attorno a basiliche come quella di San Pietro, ridefinendo i flussi di circolazione e l’assetto della città. La progressiva cristianizzazione della città è evidenziata attraverso esempi di edifici storici e monumenti rilevanti, che riflettono il cambiamento della topografia urbana in risposta agli sviluppi religiosi e culturali.
La continuità e il cambiamento nell’architettura
La lezione analizza inoltre la continuità e il cambiamento nell’architettura romana, mettendo in evidenza il confronto tra i resti pagani e le nuove costruzioni cristiane. Viene sottolineata la difficoltà di identificazione degli edifici di culto cristiani nei primi secoli, nonostante la loro crescente importanza, e come l’architettura ecclesiastica si sia evoluta nei secoli successivi, trasformando spazi e funzioni.
La reazione della città alla cristianizzazione
La discussione si sposta poi sulla reazione degli abitanti di Roma alla crescente cristianizzazione, esaminando eventi significativi come la rimozione dell’altare della Vittoria dalla Curia. Ciò funge da spunto per una riflessione più ampia sulla complessità del cambiamento religioso e culturale in un contesto urbano dominato ancora da tracce del passato pagano.
L’eredità della Roma antica nel Medioevo
Infine, viene messa in luce la continua interazione tra il patrimonio romano classico e la nuova identità cristiana, con i monumenti antichi fungenti da punti di riferimento topografici sia nella Roma medievale che in quella moderna. Questa parte della lezione enfatizza come la memoria storica dei monumenti classici abbia continuato a influenzare la percezione spaziale e culturale della città anche dopo il crollo dell’Impero Romano, ponendo le basi per la futura evoluzione urbana.
DOCENTE
Penelope Filacchione
Penelope Filacchione. Storica dell'arte specializzata in iconografia e iconologia cristiana presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana.
Dal 2003 è docente Archeologia e Storia dell'arte classica e cristiana antica presso la facoltà di Lettere classiche e cristiane antiche dell'Università Pontificia Salesiana e ha tenuto la cattedra di Archeologia cristiana per la facoltà di Teologia del medesimo ateneo. Insegna presso le Scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale e presso la Link Campus University.
Ha collaborato alla redazione della rivista Archeo - Attualità del passato, ha all'attivo numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative e ha curato e scritto - insieme a Caterina Papi - il volume Archeologia cristiana - coordinate storiche, geografiche, culturali edito dalla LAS e pensato specificamente per gli studenti delle facoltà teologiche e degli atenei pontifici.

Altre lezioni
Storia dell'Arte
Perché Roma si trova dov’è? Luoghi della storia romana
LEZIONE ON DEMAND
1 ora e 30 minuti
Corso completo
Storia dell'Arte
Lo sviluppo urbanistico di Roma: dall’età Romana al Rinascimento
CORSO DISPONIBILE
6 ore
ON DEMAND